Il medico sudafricano Chris Barnard effettua il primo trapianto di cuore mentre in Medio Oriente arabi ed israeliani aggiornano la loro rivalità con un nuovo e doloroso capitolo (Guerra dei Sei Giorni) e in Bolivia viene ucciso il rivoluzionario argentino Ernesto “Che” Guevara. Tra Europa e States si assiste invece al trionfo della controcultura hippie, che sceglie come proprio epicentro spirituale il distretto di Haight-Ashbury a San Francisco. Rivoluzionare ogni aspetto del tradizionale sistema sociale, ricercare alternative rispetto al comune e cauto pensiero borghese e la ricerca di forme liberatorie di espressione, rappresentavano gli ideali di decine di migliaia di giovani che quell’estate si riversarono in sacro pellegrinaggio ad Haight-Ashbury per affermare e celebrare una nuova alba spirituale: nasce la celebre Summer of Love.
L’esuberante sensibilità artistico-sociale che anima la città californiana straborda ben presto oltre i suoi confini influenzando tra le altre cose l’industria musicale e cinematografica. Il 1967 è l’anno dei debutti leggendari di The Doors, Velvet Underground e Jimi Hendrix, i quali, in compagnia di Beatles, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Bob Dylan, The Who, Rolling Stones, Pink Floyd (…) sono il simbolo di un’audacia creativa che si traduce nell’incessante esplorazione di nuovi universi sonori e di una musica che incoraggia il pubblico a farsi un’idea propria intorno ai tabù sociali. Con Il Laureato di Mike Nichols interpretato da Dustin Hoffmann – confuso sul suo futuro ma di certo disgustato dal modello che i suoi genitori e i loro amici sembrano offrirgli – ha inizio invece la cosiddetta Hollywood Renaissance. Dietro l’angolo si annidano gli scontri e le tensioni del Sessantotto ma quell’anno un clima di amore e ospitalità pervade l’aria: «se stai andando a San Francisco, assicurati di indossare fiori tra i capelli» recitano i versi del singolo San Francisco, un inno della Summer of Love.

The Doors – The Doors
Non solo Franco, Salazar e Ceausescu, l’onda lunga dei fascismi europei raggiunge quella primavera anche la penisola ellenica. Il 21 aprile del 1967 un gruppo di ufficiali dell’esercito guidò un colpo di stato contro il governo greco democraticamente eletto. Nella notte, carri armati e soldati occuparono tutti i luoghi più importanti della capitale Atene, costrinsero il re ad appoggiare il golpe e diedero inizio ad un regime brutale, noto con il nome di “dittatura dei colonnelli”, che sarebbe durato per gli otto anni successivi. La lotta al comunismo fu la primaria ossessione del regime ma nemmeno l’arte fu risparmiata dall’autarchia nazionalista dei militari. I colonnelli bandirono la musica moderna di matrice occidentale dalle trasmissioni radiofoniche e promossero la musica e l’arte tradizionale.
Probabilmente però non sapevano che solo qualche mese prima (il 4 gennaio) nell’album The Doors della band omonima, originaria di Venice Beach (L.A.), modernità e tradizione si erano unite in maniera inconsueta dando vita ad una traccia leggendaria. La Grecia antica (l’Edipo re di Sofocle) ispira la più scabrosa frase della mitica The End – «And he came to a door and he looked inside Father? Yes son? I want to kill you Mother, I want to f**k you» – liturgica conclusione dell’album d’esordio della band losangelina.
Il più paradigmatico esempio dei meccanismi della tragedia greca e la psicologia freudiana si fondono in una canzone che per il frontman Jim Morrison significava ogni volta una cosa diversa: «una canzone d’addio sufficientemente complessa e universale nel suo linguaggio da essere qualsiasi cosa si voglia». Undici minuti di elettrica agonia resa ancor più eterna da Francis Ford Coppola che, molti anni dopo, la inserì in testa e alla coda del suo celebre Apocalypse Now. The Doors Album è anche il riff rockeggiante quasi punk di Break On Through, la notturna Soul Kitchen, la sognante Crystal Ship, l’atmosfera da cabaret di Alabama Song, la dionisiaca ode al sesso Light My Fire, il molto blues di Back Door Man, l’inquietante litania End Of The Night. La controversa The End («This is the end/ Beautiful friend/ This is the end/ My only friend, the end») conclude l’album, ma questo è solo l’inizio di uno strepitoso anno musicale.
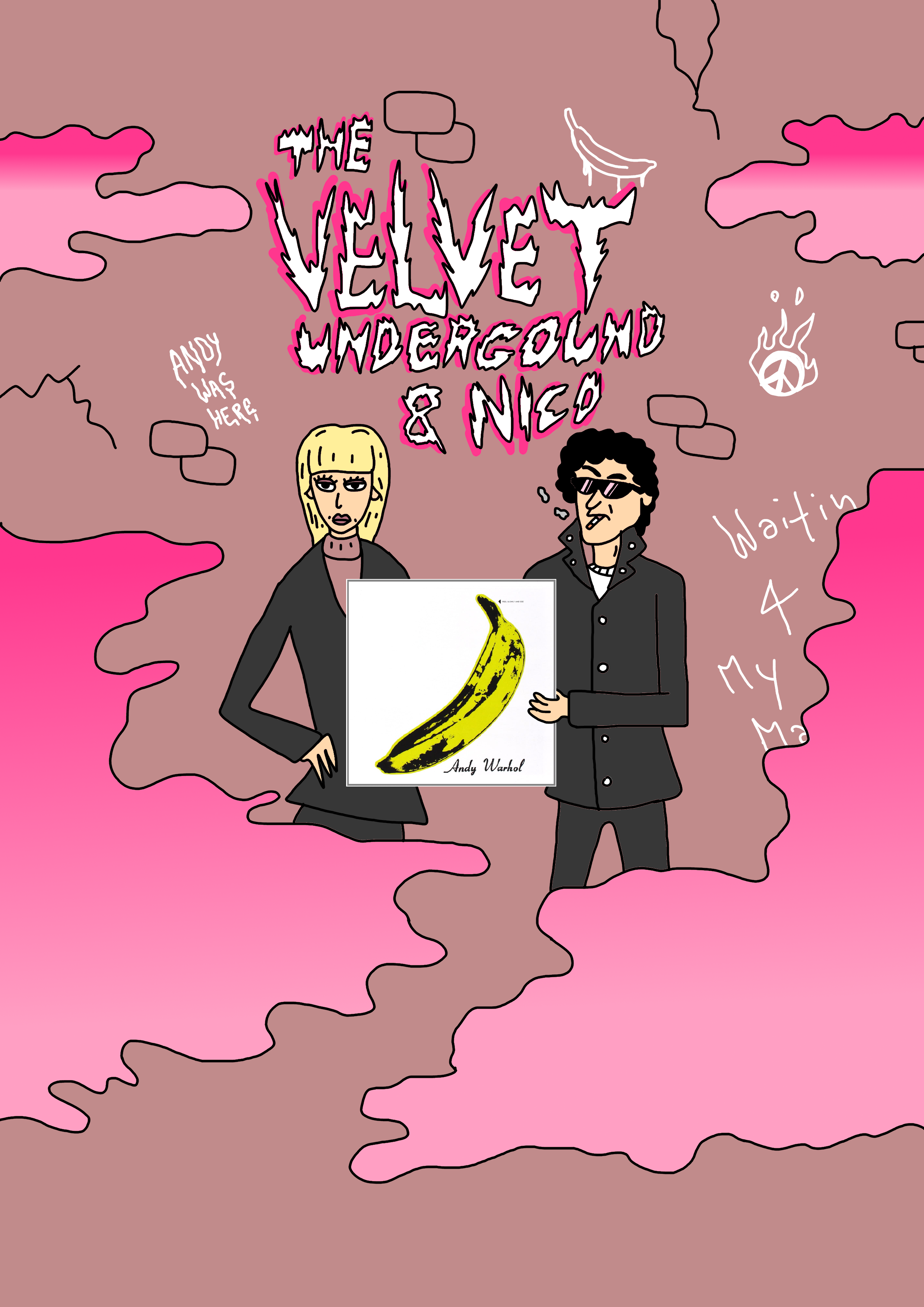
The Velvet Underground & Nico – The Velvet Underground & Nico
«Non ho niente contro i Vietcong, loro non mi hanno mai chiamato “negro”». Fino a quelle dichiarazioni nessuno, nemmeno il premio Nobel per la Pace Martin Luther King, aveva avuto il coraggio di parlare di guerra sbagliata, solo lui, il dislessico e semianalfabeta Mohammed (degno di lode) Alì, si espose. Il conto per queste sue sfacciate affermazioni gli si presentò il 28 aprile 1967 quando fu arrestato per renitenza alla leva ed impossibilitato a combattere (sul ring) per i successivi tre anni: aveva incontrato l’unico avversario che non era in grado di battere, gli Stati Uniti d’America.
Non solo Alì, non a caso per tutti ‘The Greatest’ ancora oggi, ma anche una delle più oltraggiose band della scena underground newyorkese decise quell’anno di scioccare il mondo e sfidare il sistema pubblicando uno dei più grandi album di esordio della storia del rock: The Velvet Underground & Nico. Guidati dalla regia di Andy Warhol, autore della celebre banana in copertina (che nelle edizioni originali dell’album poteva anche essere sbucciata rivelando un esplicito colore rosa), Lou Reed e soci firmano un album che, a dispetto della delicata filastrocca d’apertura Sunday Morning è una vera e propria discesa in torbidi abissi. Un “verismo” depravato, dove non c’è spazio per speranze e sogni, ma solo per un nichilismo disperato.
La quotidianità si riduce al comprare droga dallo spacciatore (I’m Waiting for the Man), raccontare un triangolo sadomaso (Venus in Furs), descrivere la dipendenza dall’eroina di un tossicodipendente nei suoi dettagli più feroci (Heroin). L’ago che buca la vena, il sangue che entra nella siringa e la volontà di annullarsi completamente nella droga, unica compagna di vita. Siamo ben lontani dalla filosofia hippy che promuoveva l’uso delle droghe come mezzo di conoscenza del mondo e di ampliamento delle capacità percettive: qui l’unico obiettivo concreto è l’incoscienza, il sonno, la morte. Il presente offrì alle melodie della perfetta Femme fatale Nico e del chitarrista Lou Reed una delusione commerciale. Troppo lontane le loro trame scabrose dai successi pop degli anni Sessanta. Dall’essere bandito in molti negozi a pietra miliare del rock, il “banana album”, com’è stato profanamente ribattezzato, è la perfetta sintesi di rock, blues, avanguardia e psichedelia, un mix letale di cui la storia della musica – ancora non lo sapeva – non avrebbe più potuto fare a meno.

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band – The Beatles
Lo sgretolamento del sogno americano, con il fallimento della guerra del Vietnam, ebbe come conseguenza l’emergere di una nuova controcultura che si oppose ai valori tradizionali attraverso la definizione di nuovi ideali di amore e spiritualità, una generale apertura all’uso di stupefacenti e un nuovo stile artistico-musicale psichedelico. Questo fenomeno di controcultura ebbe il suo epicentro nell’area di San Francisco che divenne protagonista di un vero e proprio fenomeno mediatico, venendo dipinta da radio e televisioni come il simbolo di un nuovo movimento di controcultura e protesta, di un rinnovamento spirituale e della nuova rivoluzione musicale.
L’apice della “rivoluzione” si raggiunse però a Monterey dove dal 16 al 18 giugno si svolse il Monterey Pop Festival il concerto precursore di Woodstock. Vi parteciparono più di 200.000 persone al costo di un misero dollaro, gli artisti suonarono gratis e tutto il ricavato fu donato in beneficenza. Il festival è ricordato assieme all’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (uscito sole due settimane prima) come l’apice della cosiddetta “Summer of Love“.
Sgt. Pepper riesce nell’impresa di essere avanguardia e prodotto di massa allo stesso tempo. «Concepire un intero album come se fosse stato realizzato da una band immaginaria», questa fu l’idea di Paul McCartney che permise alla band di intraprendere percorsi inesplorati. L’album è un capolavoro della pop art, dal titolo fantasioso ed extra-large che starebbe stretto in un cinguettio del XXI secolo, alla iconica copertina che affianca lo Yogi Sri Paramahansa Yogananda a Karl Marx, Oscar Wilde a Marilyn Monroe oppure l’occultista Alistair Crowley al fisico Albert Einstein (…). Poi c’è la musica. Le tracce fluiscono magicamente una dopo l’altra senza soluzione di continuità. Un brusio di un pubblico di teatro di sottofondo ha il ruolo di presentare la Banda dei cuori solitari a un’immaginaria platea. La contagiosa Sgt. Pepper parte prima e seconda, il botta e risposta With a Little Help from My Friends, la controversa ma celestiale Lucy in the Sky with Diamonds, le sonorità indiane Harrisoniane di Within You Without You ed i clarinetti old fashion di When I’m Sixty-Four non hanno bisogno di ulteriori presentazioni. Il finale A Day in The Life è una delle vette artistiche più alte mai toccate dalla band. L’atmosfera psichedelica e l’orchestra che si produce in un crescendo ci restituiscono l’idea di «un suono che parte dal nulla e arriva alla fine del mondo» come era nelle intenzioni di John Lennon poi, improvvisamente, sul più bello la musica scompare, assorbita dallo stesso chiacchiericcio dal quale era sorta.
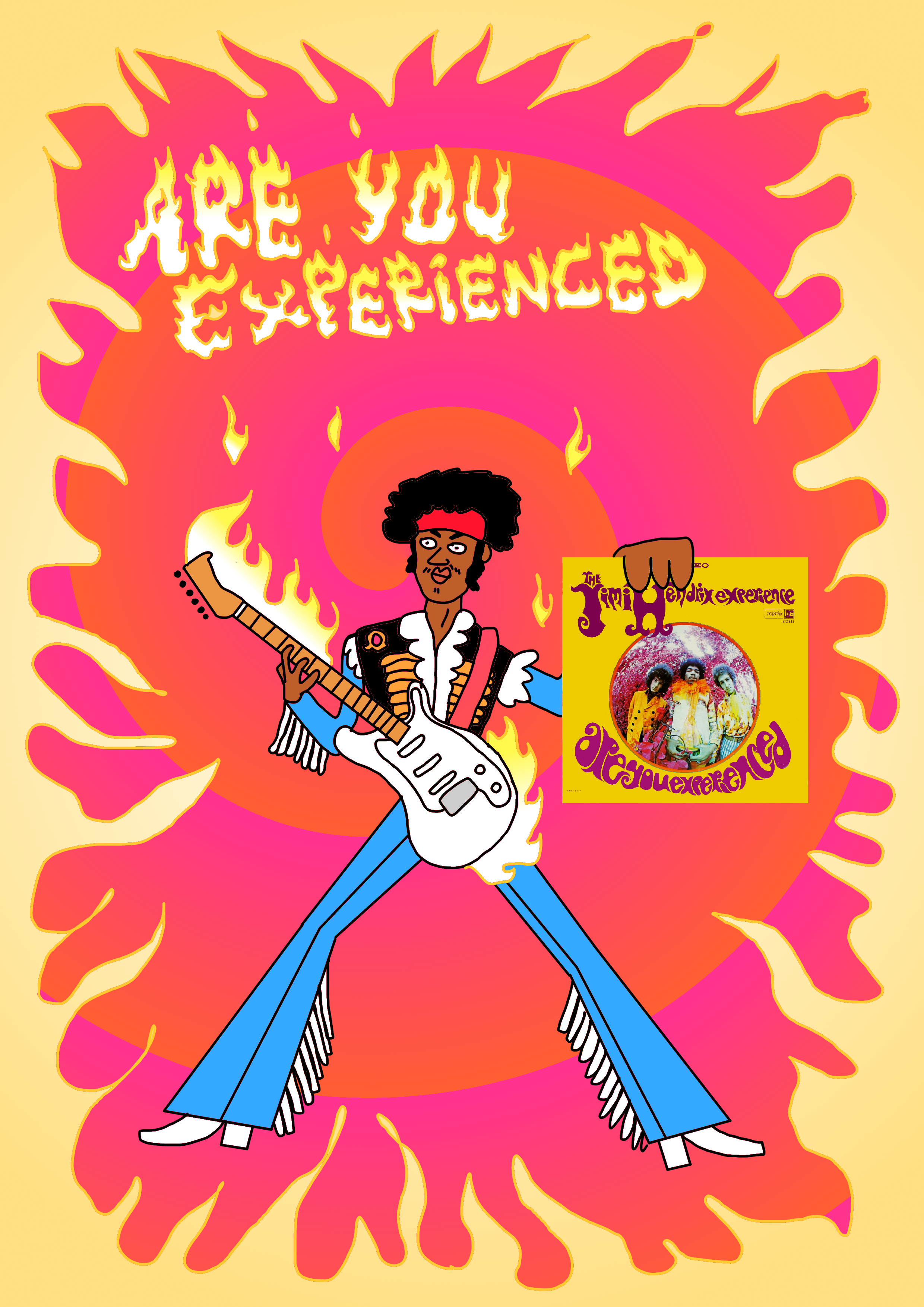
Jimi Hendrix Experience – Are you experienced
Rimaniamo a Monterey perché il 18 giugno, l’ultimo del Festival, sul palco sale un ventiquattrenne poco conosciuto che ha fatto la spola tra i suoi States e il Regno Unito e che riesce per l’occasione ad esibirsi solo grazie all’insistenza di Paul McCartney che lo ritiene «an absolute ace on the guitar». Il chitarrista ha da poco pubblicato il suo primo album “Are You Experienced” insieme al bassista Noel Redding e il batterista Mitch Mitchell, un gruppo che porta il suo nome: The Jimi Hendrix Experience. Quella sera Hendrix suonerà nove brani per un totale di quaranta minuti, di cui cinque tratti dall’album: la violenta Hey Joe, l’irriverente Foxy Lady, l’aspro hard rock Can you see me, la dolce ballata Wind Cries Mary e l’iconica Purple Haze, uno dei riff più celebri di sempre. A questo punto arriva il momento di eseguire l’ultimo brano in scaletta, Wild Thing, per quello che sarà l’acme del festival e diverrà uno dei momenti più iconici dell’intera storia del rock.
Di fronte a chitarristi del calibro di Eric Clapton e Pete Townshend Jimi non vuole sfigurare e decide di “sacrificare” la sua Fender già sollecitata oltre ogni immaginazione durante l’esibizione, mimando rapporti sessuali, suonata con i denti e dietro la schiena. «Voleva fare meglio di Townshend (che aveva distrutto il suo strumento poco prima dello show di Hendrix) e chiese se qualcuno del pubblico aveva da accendere…» – ricorda uno dei manager della sua etichetta – «poi dopo averle dato fuoco con il liquido per accendini decise di scaraventarla contro il palco e gli amplificatori, ottenendo suoni infernali e primitivi». Quella serata il guitar-hero Hendrix la ricorderà con queste parole: «Mi è sembrato che stessimo riuscendo a infiammare il mondo intero (…) Così ho deciso di distruggere la chitarra alla fine della canzone. Come forma di sacrificio. Si sacrificano le cose che si amano. Io amo la mia chitarra».
Illustrazioni di Francesco Moffa









